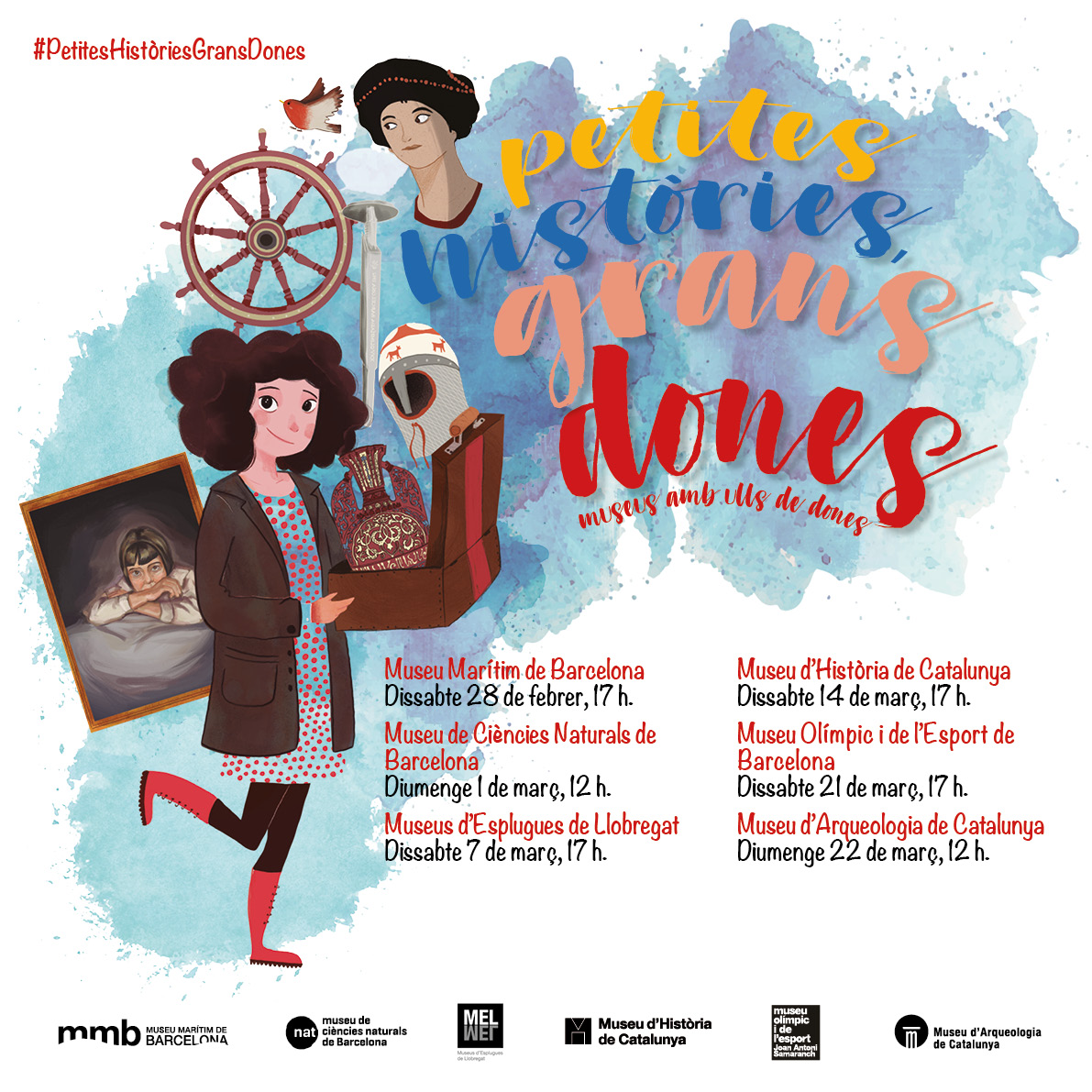La scoperta di una rappresentazione dell’Arca dell’Alleanza nella chiesa di Sants Màrtirs Just i Pastor a Barcellona ha suscitato grande interesse. Questa scoperta, inizialmente avvolta nel mistero, ha portato storici, ricercatori e persino moderni avventurieri a speculare sulla sua origine. Tuttavia, il mistero è stato risolto e rivela una storia affascinante che collega Barcellona a importanti eventi storici e culturali del XIX secolo.

Una scoperta inaspettata
La notizia della rappresentazione dell’arca in questa cappella, un’area dimenticata della chiesa, ha generato una pletora di teorie. I lettori e gli studiosi hanno formulato ipotesi, anche piuttosto creative, su come sia arrivata lì. Alcune delle spiegazioni suggerite includevano una possibile donazione dall’Esposizione Universale del 1888, un collegamento con l’antico teatro Liceu o elementi rituali della Settimana Santa. Tuttavia, la verità si è rivelata più semplice ed estremamente interessante.
Il ruolo di Manel Alonso
La scoperta non sarebbe stata possibile senza il duro lavoro di Manel Alonso, il custode del patrimonio storico della chiesa. Con dedizione, Alonso si è immerso negli archivi e nei documenti storici per svelare il mistero. Dopo una meticolosa ricerca, ha trovato un documento del 1920 che fa luce sulla questione: l’opera è stata progettata dall’architetto Josep Vilaseca i Casanovas, altrimenti noto per la sua famosa opera, l’Arco di Trionfo. Vilaseca, nel 1876, fu incaricato di creare questo pezzo per l’altare, che rientrava nella tradizione dell’epoca di adornare maestosamente gli altari durante le feste religiose.
Influenze d’epoca e un’eredità nascosta
Nel XIX secolo, le chiese di Barcellona cercavano di distinguersi il Giovedì Santo e il Venerdì Santo con elaborati monumenti per commemorare l’Ultima Cena e la Passione di Cristo. Barcellona faceva a gara nella bellezza dei suoi altari e luoghi come la Cattedrale, la chiesa di Pi e Sant Just erano visitati da cittadini impressionati dalle loro decorazioni. L’opera di Vilaseca, con i suoi dettagliati ornamenti di ispirazione egizia, abbelliva l’altare maggiore della chiesa di Sants Màrtirs Just i Pastor in quei giorni solenni.
L’arca, progettata con iscrizioni ebraiche e ornamenti egiziani, rifletteva la mania dell’epoca per l’esotismo orientale, un interesse che si diffuse in Europa nel XIX secolo. L’opera, alta ben 1,70 metri e larga 2,89 metri, faceva parte di un ricco patrimonio artistico che purtroppo fu dimenticato quando fu spostata in una cappella inaccessibile durante i lavori di ristrutturazione del 1923.
Divulgazione e ripristino
Nel 2015, l’installazione di una nuova scala a chiocciola ha consentito di accedere nuovamente alla cappella dimenticata, permettendo di riscoprire l’arca e di ripristinare la sua storia nel contesto culturale della chiesa. La coincidenza di stili architettonici con l’Arco di Trionfo e altri elementi della città evidenzia l’abilità di Vilaseca e rivela una rete di connessioni artistiche all’interno di Barcellona.
La rappresentazione dell’Arca dell’Alleanza nella chiesa di Sants Màrtirs Just i Pastor è più di un semplice ornamento religioso: è la testimonianza di una ricca tradizione culturale e un simbolo del movimento artistico dell’epoca. Grazie al lavoro di persone impegnate come Manel Alonso e gli archivisti di Barcellona, pezzi come questo servono a illuminare aspetti dimenticati del passato e a ravvivare l’interesse per la storia locale.
Un’eredità rivelata
La scoperta e il chiarimento del mistero dell’arca di Sant Just è un trionfo per il patrimonio culturale di Barcellona. Questa scoperta non è stata solo un ritorno al passato per gli storici, ma ha anche ricollegato i cittadini a un momento vibrante della loro storia artistica e architettonica.
In breve, la ricerca ha ribadito che le chiese non sono solo spazi di culto, ma anche punti di incontro per l’arte e la storia di una città. Questa scoperta ci invita a riflettere sul ruolo che l’arte religiosa svolge nel nostro patrimonio culturale e sul modo in cui interagiamo con la storia quotidianamente.